
(di Tindaro Gatani) – Il 31 dicembre 2022 si è spento, all’età di 93 anni, nella sua Herisau, in Svizzera, Adrian Wolfgang Martin poeta, scrittore, pittore e psicanalista, amico di Napoli e delle Isole Eolie, che egli ha scoperto negli anni ’50. Nel 1962 ha acquistato una casa a Salina, dove si recava per sei mesi all’anno, insieme alla moglie Regina e ai due figli Flandrina e Donato.
Nel 1976 ha istituito la Fondazione Salina con sede a Leni, raccogliendo, in Svizzera, i fondi necessari, per la promozione socio-culturale dell’isola e la formazione professionale della gioventù locale.
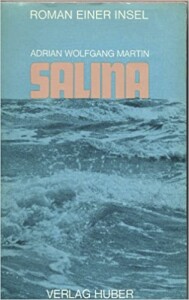
A me piace ricordarlo per il suo Giano di Napoli, la «più consapevole prova d’amore per la città», attingendo ad alcuni miei contributi già pubblicati su Agorà di Zurigo e Arte&Storia di Lugano.
Delle diverse «anime» o «facce» di Napoli non c’è scrittore italiano o straniero che, visitandola, non ne abbia parlato. L’instabilità e l’apparente contraddittorietà dei napoletani hanno avuto un cantore nello stesso Salvatore Di Giacomo in versi meravigliosi ed indimenticabili. Come non ricordare la sua «strana primavera» partenopea col cielo azzurro da una parte e scuro dall’altra: «Llà ‘o sole s’arravoglia ‘nt’a nu velo niro, e ‘a ccà pare ‘na bella jurnata…».
E poi tutti i luoghi comuni cantati da scrittori e poeti, dai più antichi ai più recenti: Napoli è stata descritta come città godereccia, paradiso di oziosi e buontemponi, dipingendo il «colore locale», fatto di vedute incantevoli e di scene che hanno per soggetto i soliti guappi, pezzenti, scugnizzi…
Nel Giano di Napoli, uscito in tedesco nel 1966, e nelle edizioni italiane del 1969 e 2005, non troviamo nulla di tutto questo.
«Libro di sottile antropologia letteraria», il Giano di Napoli è, per l’allora direttore del Correre della Sera, Gaspare Barbiellini Amidei, «una navigazione fra simboli che non si sa se sono vivi o morti, dotati, come molti a Napoli, della capacità quotidiana di vedere morire la morte… e anche questo è fascino di un lavoro singolare, rispettoso della complessità umana nella esplorazione urbana». Perché Napoli è una città «felice e disperata», che tuttavia «non si accontenta di essere banalmente speranzosa, considerando la speranza una incerta letizia» (Corriere della Sera, 25 maggio 2005, p. 37).
Per il suo stile di indagine, «da psicologo junghiano qual è», Martin, per Ugo Calindri, e stato «uno dei pochissimi scrittori che veramente ha compreso Napoli… come supremo e ancora intatto simbolo dei simboli, grande calderone psichico, creatura istintiva e incompiuta la cui sorte è quella di uno spettro mitologico» (La Campania, 2 giugno 2005).
Gli fanno eco Marino Niola su Il Mattino (27 aprile 2005) e Vittoria Fiorelli su La Repubblica (17 maggio 2005). Per il primo «l’autore si cala nelle profondità del cuore di Partenope per ritrovare la cifra enigmatica nascosta sotto il movimento vorticoso degli eventi storici che agitano la città», nel tentativo «di catturare la vorticosa fluvialità delle vicende di Napoli in una figura costitutivamente doppia come quella dell’antico dio delle porte… Januarius». Per la seconda, quello di Martin «è un libro speciale attraverso il quale un raffinato intellettuale svizzero cerca di trasmettere il legame profondo che ha intessuto con la città. E lo fa con una lingua antica e colta…». La su è insomma un’immagine «velata dal mito» e nello stesso tempo una meditazione sulla Napoli di oggi.
Martin ha scoperto l’intima essenza della città, indagando i vari aspetti apparentemente contrastanti della napoletanità che, nei loro contrasti, si completano, integrandosi a vicenda, come facce della stessa medaglia o meglio come il doppio volto appunto di Giano.
Napoli è bella perché è varia e questa varietà ha una sua interdipendenza. Così mentre da una parte, nel capitolo «Il gobbo», egli rappresenta la perenne teatralità del suo popolo; dall’altra, in «L’uomo dei gamberi», schizza la predisposizione dei napoletani alla malinconia.
Martin entra nell’intimo del «Corpo di Napoli», si intitola così il secondo capitolo, perché l’uomo si capisce soltanto attraverso la conoscenza dei simboli del suo inconscio e dei miti del suo popolo. E Napoli è un libro aperto, un campo di studio ineguagliabile, perché, nel vario gioco della vita così come nei fatti profani, il napoletano è un individualista, che tuttavia non si distacca mai «da un intreccio di concetti ancorati al mito, di leggi le cui origini risalgono ad un antichissimo ed irremovibile prototipo».
Ed infatti, in nessun altro luogo, come l’autore sottolinea nel terzo capitolo, il mistero dell’uomo può rivelarsi più ricco di sfumature e più verace… in tutta la sua drammatica grandiosità.
Il Giano è dedicato a John Marbach, allora direttore della locale Scuola svizzera di Napoli, che lo conduce idealmente per mano a scoprire ed a capire i misteri della città . Guai a criticarla «con la ragione», dice Martin, ne verrebbe fuori il quadro di una cosa «disunita». Solo chi ama Napoli, la può comprendere «come entità indissolubile e riconoscerà come ideale la sua immagine mitica». «Gli ideali», infatti, «non possono essere imitati razionalmente». «Bisogna viverli e, ogni giorno, meditarci sopra…».
Quella di «Adrian Wolfgang Martin — come ha scritto Felice De Filippis, in «Roma», 5.8.1969 — è la più bella prova di consapevole amore, di comprensione che uno straniero poteva dare a Napoli». Martin si stacca, infatti, completamente dai vecchi condizionamenti psicologici che da Goethe in poi hanno costituito i soliti clichés letterari sui meridionali.
L’opera di Martin, come nota Elena Croce in «Napoli vista da uno svizzero», «Il Veltro», 4 -5, Roma, 1967 — ha immagini di grande immediatezza visiva, e non ricalca mai i pure amabili clichés della illustrazione folcloristica».
Nel Giano non c’è posto allora per l’iconografia e l’aneddotica ispirate agli abitanti, alle bellezze del golfo ed alla vita gaia e dolente. L’immagine che Martin ci dà di Napoli è un’altra. Egli la scopre strappando la maschera che nasconde la sua vera anima. Così, la sostanza di queste meditazioni scaturisce da impressioni vere, da avvenimenti ed incontri vissuti in prima persona.
Qualunque cosa egli veda diventa per lui trasparente: dietro al semplice venditore scorge l’antico Mago Virgilio e, nella millanteria del finto gobbo scopre l’amore per la messa in scena, ma nota anche con simpatia l’indulgenza di coloro che assistono allo spettacolo. E lo fa «raggiungendo nelle sue narrazioni effetti sorprendenti e quasi sempre non privi di poesia» (Luigi De Lillo, in «La Voce di Napoli», 21 giugno 1969).
Martin ci conduce nei quartieri popolari dove percepisce, con particolare evidenza, la sopravvivenza di antichissimi arcaici prototipi, di elementi pagani amalgamati con immagini cristiane. Ed è proprio questo che conferisce a Napoli il suo fascino, poiché ambedue i mondi — quello pagano e quello cristiano — sono, ancora oggi, vivissimi ed onnipresenti. Il libro si articola in ventidue «scene», «che non sono bozzetti perché del bozzetto evitano il manierismo» (P.D.N., in «Paese Sera», 11 maggio 1969).
Sono capitoli che con «un’andatura fra narrativa e saggistica, si sentono subito nati dall’osservazione diretta, ma subito dopo avviati a farsi meditazione approfondita sui dati di una cultura classica in cui la Grecia e la grecità risultano come componenti essenziali ed indispensabili nella comprensione più vasta del fenomeno umano napoletano… in un senso mitico della vita (e nel mito coincidono e confluiscono elementi tragici ed elementi comici, verità minuscole e temi di profonda religiosità, natura e cosmo, gioco ed artificio in una composizione affascinante e complessa)» che «ha dato occasione a Martin di scrivere pagine certamente notevolissime per la loro interiore forza e per la loro significazione» (Mario Stefanile, in «Il Mattino», 15 maggio 1969).
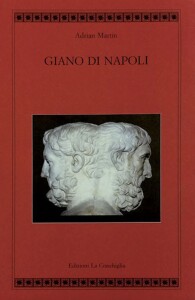 Il Giano di Napoli apre dunque la strada per la comprensione dell’essere umano. È un’opera che ritrae la personalità complessa e la potenzialità del nostro Meridione: ardente nei suoi colori, passionale nell’esplosione della sua potenza.
Il Giano di Napoli apre dunque la strada per la comprensione dell’essere umano. È un’opera che ritrae la personalità complessa e la potenzialità del nostro Meridione: ardente nei suoi colori, passionale nell’esplosione della sua potenza.
A proposito di simboli, Martin identifica Napoli con il fuoco purificatore. Non solo quello del Vesuvio, ma anche quello della vita che è un processo di combustione che dà calore e quindi amore. E per questo i napoletani vedono nella luce del fuoco, opposta alle tenebre, il simbolo della supremazia del bene sul male.
Per combattere i mali di Napoli, Martin invoca addirittura l’eroe della mitologia nordica. Alla vista di un’edizione del Parsifal abbandonata sulla bancarella della città, gli balena «il pensiero, quasi assurdo, che un poema del Parsifal ai nostri giorni non potrebbe svolgersi in nessun altro luogo che a Napoli». La città che «riunisce in sé tutte le premesse di una scena mitico-realistica». Ed infatti: «La strada della vera ricerca del [sacro] Graal non dovrebbe più, oggi, portare per foreste pericolose e tavolate principesche, ma attraverso la più cruda miseria umana».
Solo così «l’eroe sarebbe costretto ad affrontare ogni forma di tribolazione spirituale ed intellettuale, accettandola e soffrendone, e ad imprimere nella sua memoria, in modo incancellabile, la visione della fame, dei senzatetto e dell’infermità…».
Anche perché: «Il Parsifal moderno deve essere un guaritore», che supera le discordie e che «dalla magica potenza del suo cuore» emana «quello sconfinato spirito di conciliazione, così estraneo all’intelletto». E «l’immagine che egli segue e di cui si fa servitore ha due volti pur essendo un’unica testa: Giano».
Solo quando Parsifal «avrà percorso Napoli, quando ne avrà sofferto, quando l’avrà accolta in sé e riconosciuta, la sua missione sarà compiuta. Avrà trovato se stesso nello specchio del suo mondo».
Ed allora: soltanto allora, per lui risulta giusto il detto ingiustamente banalizzato: «Vedi Napoli e poi muori».





 13 Gen 2023
13 Gen 2023
 Inviato da @Cd_Admin
Inviato da @Cd_Admin 
















